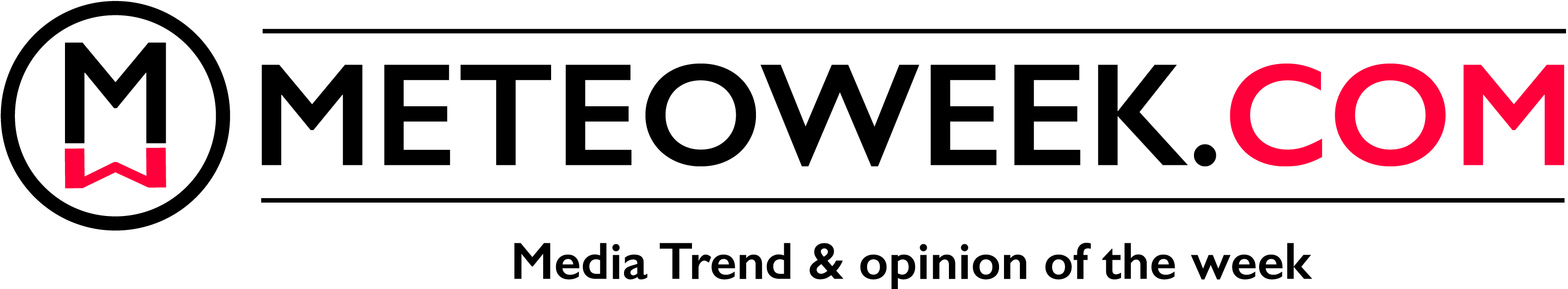Nancy Pelosi a Taiwan: cosa c’è in gioco nella visita della leader dem nell’isola

La visita della presidente della Camera Usa a Taiwan è un gesto che si inserisce in uno scenario geopoliticamente teso.
Il fatto che la presidente della Camera Usa, l’esponente democratica Nancy Pelosi, si sia recata in visita a Taiwan costituisce un gesto di solidarietà per un’isola sotto la costante spada di Damocle di un’invasione-annessione da parte della Cina.

Un riconoscimento importante proveniente dalla terza carica istituzionale americana. L’ultima volta che successo fu nel 1997. Allora ad andare a Taipei era stato il repubblicano Newt Gingrich, all’epoca presidente della Camera. Successivamente si sono verificate visite di delegazioni parlamentari americane, anche se non allo stesso livello. A ogni visita Pechino ha reagito con durezza davanti a mosse che interpreta come «interferenze» in una «provincia ribelle». Stavolta le minacce cinesi si sono spinte ben oltre, fino a prefigurare un’escalation della tensione militare tra le due superpotenze. Un evento che può essere inquadrato meglio se visto da prospettive differenti. Quelle dei quattro protagonisti politici principali della vicenda: Nancy Pelosi; il presidente americano Joe Biden; quello cinese Xi Jinping; e la presidente taiwanese Tsai Ing-wen.
Nancy Pelosi, 82 anni, è la prima donna presidente della Camera a Washington. Si avvicina per lei la fine del mandato, tanto più che a novembre i repubblicani potrebbero riavere la maggioranza alla Camera. Il collegio elettorale di Pelosi è San Francisco, città dove si trova la più antica Chinatown degli Usa oltre a una importante comunità sino-americana. La presidente della Camera si è sempre segnalata per il suo attivismo nella difesa dei diritti umani in Cina. A cominciare dal gesto plateale del 1991, due anni dopo la strage di Piazza Tienanmen, quando andò a manifestare proprio in quella piazza in segno di solidarietà con gli studenti morti (con uno striscione che le costò l’immediato allontanamento da parte della polizia).
Nel 2015 lo stesso presidente Xi Jinping le concesse il raro privilegio di poter visitare il Tibet, la regione chiusa ai diplomatici e ai giornalisti stranieri dopo svariate proteste della popolazione locale contro il regime di Pechino. Nancy Pelosi è stata anche la leader politica Usa di più alto livello istituzionale ad andare in visita a Kiev dopo l’aggressione militare russa. Il suo viaggio a Taiwan era già stato previsto per aprile, ma venne rinviato a causa della sua positività al Covid. La sua missione a Taipei è circondata da un vasto sostegno bipartisan al Congresso di Washington. Diversi deputati – sia da parte democratica che repubblicana – hanno detto che non farla avrebbe rappresentato un grave cedimento, perché significherebbe riconoscere al governo cinese un diritto di veto su chi può recarsi in visita a Taiwan. Col suo viaggio la Pelosi intende manifestare un supporto all’isola governata democraticamente, per dare un segnale. Cioè che il sostegno americano a Taiwan non è limitato alla Casa Bianca ma riguarda anche i rappresentanti eletti dal popolo americano. Incide anche, con ogni probabilità, la preoccupazione di non rifare gli errori commessi con Putin in Ucraina quando la prudenza dimostrata dalla Casa Bianca (la promessa di «non mandare scarponi sul terreno», il ripetuto rifiuto di istituire una no-fly zone, l’offerta di evacuazione di Polonia a Zelensky) furono interpretate dal Cremlino come un tacito semaforo verde all’aggressione militare.
Il gioco di Biden sul filo del rasoio

Quanto a Joe Biden, c’è da dire che si sarebbe volentieri risparmiato le nuove tensioni. Gli scorsi giorni ha cercato di persuadere Nancy Pelosi a rinviare il viaggio. Con una mossa irrituale ha fatto sapere che anche il Pentagono giudicava inopportuna la visita per via delle conseguenze che potrebbe scatenare sul piano militare, nel caso in cui i cinesi optassero per delle dure rappresaglie (come ad esempio una qualche specie di disturbo o intercettazione dell’aereo militare su cui viaggia la Pelosi). Ma ha dovuto accantonare i suoi richiami per non cadere nell’accusa di interferenza verso il potere legislativo. È una cosa difficile da spiegare a Pechino, dove il sistema politico è «verticale» e obbedisce a una sola catena di comando, ma a Washington il presidente non gode di alcun potere sul Congresso. Biden già si è spinto molto in là per esercitare una persuasione sulla sua compagna di partito. Anche lui, tuttavia, non può dare l’impressione di farsi intimidire dalle minacce di Xi Jinping, che pochi giorni fa nel corso di un colloquio telefonico gli ha detto: «Chi gioca con il fuoco finirà bruciato». Il presidente americano deve anche tenere in considerazione le ricadute sugli alleati strategici degli Usa in Estremo Oriente, Giappone e Corea del Sud in primis. Se gli americani non difendessero Taiwan da un’aggressione cinese, Tokyo e Seul potrebbero dubitare della protezione Usa e cadere nelle braccia di Pechino. Gli Usa sono a tutti gli effetti una potenza dell’Indo-Pacifico e non possono lasciare al suo destino quest’area geopolitica dove tanti alleati fanno assegnamento sulla sua protezione.
Biden deve muoversi, quasi come un equilibrista, sul filo della cosiddetta «ambiguità strategica». Il dossier Taiwan è difficile da gestire perché dal 1978, in coincidenza col disgelo delle relazioni diplomatiche tra Usa e Cina, la politica estera americana riconosce la Repubblica Popolare come «unica Cina», rovesciando il riconoscimento di segno opposto adottato nel 1949 (quando era Taiwan «l’unica Cina» per gli Usa, che nel corso della guerra civile cinese avevano sostenuto le forze nazionaliste di Chiang Kai-shek, successivamente sconfitte ed esiliate sull’isola). Contemporaneamente gli Usa seguono il principio che una eventuale riunificazione potrebbe avere luogo solo in maniera pacifica e dunque con l’assenso da parte di Taiwan. Se la Cina tentasse invece l’avventura dell’annessione forzata, Biden ha promesso che gli Usa interverranno militarmente per difendere Taiwan. Una uscita interpretata anche come il tentativo di non ripetere gli errori compiuti in Ucraina dove secondo alcuni la scarsa determinazione americana ha spalancato le porte all’invasione russa.
La visione di Xi Jinping
Per i cinesi Taiwan fa parte della Repubblica Popolare, è una provincia ribelle» da ricondurre sotto la piena sovranità e giurisdizione di Pechino. È questa la dottrina ufficiale della Repubblica Popolare cinese a partire dalla sua fondazione nel 1949 ad opera di Mao Zedong. Sotto questo punto di vista Xi sé in piena continuità coi suoi predecessori. Tuttavia negli ultimi anni sono cambiati toni e insistenza. Il nazionalismo è tornato in auge dalla presa di potere di Xi Jinping nel 2012. I riferimenti a Taiwan ricorrono con regolarità nei suoi discorsi, la riunificazione è diventata una questione di prestigio e di orgoglio nazionale. La protezione americana a Taiwan viene accostata al «secolo delle umiliazioni», l’Ottocento, con le sconfitte patite dalla Cina contro la Gran Bretagna nelle Guerre dell’Oppio e lo stabilimento di concessioni (Hong Kong, Canton, Shanghai).
Anche in passato ci sono state prove di forza, diverse sono state le «esercitazioni per un’invasione». Quella più recente su vasta scala è stata nel 1995, quando Pechino effettuò una serie di lanci missilistici nelle acque di Taiwan. Più trascorre il tempo, più i rapporti di forza militari si muovono a favore delle forze armate cinesi. Anche il Pentagono riconosce che una difesa dell’isola di Taiwan si farà sempre più difficile, o destinata all’insuccesso. Una soluzione pacifica, negoziata e consensuale sembra essere preclusa visto il modo con cui Xi Jinping ha affrontato la questione di Hong Kong: smantellando lo stato di diritto e le libertà, con una normalizzazione dell’ex colonia britannica e la repressione poliziesca. Xi così ha liquidato l’autonomia di Hong Kong, cancellando il modello «una nazione, due sistemi» promesso da Deng Xiaoping nel 1997 ai cittadini dell’isola. Il presidente cinese è pur sempre un autentico leninista, che coltiva il primato del partito comunista come architrave della sua visione politica. È sempre meno verosimile che Taiwan possa essere unificata con la Cina mantenendo le proprie istituzioni democratiche e le proprie libertà. Quando ha minacciato Biden – «chi gioca col fuoco finirà bruciato» – Xi ha scatenato un’escalation di minacce verbali da parte dei suoi sottoposti – sia civili che militari – che hanno fatto paventare reazioni spaventose al viaggio della Pelosi a Taiwan. Così Xi, per non perdere la faccia, dovrà dare qualche seguito alle sue minacce. Tra due mesi ci sarò l’assemblea che dovrà ratificare il suo terzo mandato, incoronandolo di fatto come una sorta di «imperatore a vita», per cui è l’ultimo momento in cui il presidente cinese può permettersi di fare una brutta figura.
Taiwan, unica democrazia cinese al mondo

Tsai Ing-wen, 66 anni, è la prima donna eletta presidente a Taiwan. Fa parte del partito democratico-progressista, il più distante sul piano ideologico dall’idea dell’appartenenza alla Cina e dunque della riunificazione. È il partito legato a doppio filo alla democratizzazione dell’isola. Agli inizi, dopo il 1949, Taipei ebbe un regime autoritario di destra, il partito democratico nasce nel 1986, un anno prima dell’abolizione della legge marziale e l’avvio delle riforme liberali. Il sangue freddo con cui fino ad ora Tsai e l’opinione pubblica di Taiwan hanno guardato all’aumento della tensione trova la sua origine forse anche in una certa assuefazione: le minacce cinesi rappresentano una costante, e lo stesso vale per gli sconfinamenti di cacciabombardieri di Pechino sui cieli dell’isola.
L’assuefazione potrebbe condurre anche a una sottovalutazione del pericolo (come accaduto a Zelensky davanti agli avvertimenti dell’intelligence americana e inglese sui preparativi dell’aggressione di Mosca). La presidente di Taiwain, e con lei la maggioranza del suo popolo, sembra rassegnata all’anomalia per cui la riunificazione con la Cina è ampiamente indesiderabile. Ma sa anche che la piena autonomia (ovvero una dichiarazione d’indipendenza) appare irrealistica perché costituisce una «linea rossa» da non oltrepassare agli occhi della Cina. Anche i taiwanesi si illusero – come tanti occidentali – che la Cina si potesse “democratizzare” attraverso l’economia di mercato, cosa che non si è verificata. Intanto la popolazione taiwanese si è «de-sinizzata» sviluppando una propria identità culturale, in particolare nelle giovani generazioni che si sentono molto distanti dai cinesi.
Taiwan rappresenta l’unica democrazia cinese al mondo. Una differenza emersa in pandemia, dove Taiwan è riuscita a arginare il contagio, con bilancio di vittime molto ridotto rispetto all’Occidente. Un risultato ottenuto non coi metodi autoritari della Cina, ma attraverso la disciplina spontanea, il rispetto delle regole, al senso di dovere della comunità caratteristici della cultura confuciana (che hanno avuto successo anche in Giappone e in Corea del Sud). L’Occidente di recente ha cominciato ad aprire gli occhi sulla propria dipendenza da Taiwan, che produce il 60% di tutti i semiconduttori al mondo. Uno status, quello di superpotenza tecnologica, che però non è una salvaguardia contro una possibile invasione cinese, al contrario. Recentemente si è fatto riferimento a una «strategia del porcospino», la lezione appresa da Taiwan dall’Ucraina: munirsi di armamenti studiati su misura per rendere costosa e dolorosa un’aggressione militare, se l’aggressore risulta molto più potente e grosso.